|
ROLLING THUNDER
di @Luca
Abiusi
 Può trasfondere claustrofobia, Rolling Thunder, nell’Ottantasei. Folgorati dalla struttura a scorrimento d’impronta Namco si concluse che non
doveva essere un semplice platform, con questa andatura evidentemente anomala, per il
periodo, che prevede la possibilità di utilizzare armi da fuoco col limite delle
munizioni che esauriscono. Il protagonista può balzare verticalmente sulle piattaforme
sovrastanti o sottostanti, un po’ come avviene in
Shinobi. In sala giochi si
diceva: “facciamo una partita a 007”. Del resto Rolling Thunder,
coi suoi continui riferimenti alla saga di James Bond, avrebbe potuto essere un perfetto tie-in
dedicato, e in molti ancora si ignora la reale titolazione del gioco: «Luca
scusami ma ti ricordi il titolo di quel gioco dove stavano i nemici incappucciati e uno
che sparava tipo 007?», «sì, ma non te lo dirò mai». I più esperti
utilizzatori di Rolling Thunder facevano ricorso al trucco del torno indietro perché
sono uomo di mondo e scopo, dal momento che ottenuta la prima infornata di munizioni
si può varcare la porta apposita per nuove ricariche formato mitra, e così per diverse
volte, tempo permettendo. Perché bisogna far presto, ché hanno rapito la nostra Leila e
chissà che le fanno, se non arriviamo. Può trasfondere claustrofobia, Rolling Thunder, nell’Ottantasei. Folgorati dalla struttura a scorrimento d’impronta Namco si concluse che non
doveva essere un semplice platform, con questa andatura evidentemente anomala, per il
periodo, che prevede la possibilità di utilizzare armi da fuoco col limite delle
munizioni che esauriscono. Il protagonista può balzare verticalmente sulle piattaforme
sovrastanti o sottostanti, un po’ come avviene in
Shinobi. In sala giochi si
diceva: “facciamo una partita a 007”. Del resto Rolling Thunder,
coi suoi continui riferimenti alla saga di James Bond, avrebbe potuto essere un perfetto tie-in
dedicato, e in molti ancora si ignora la reale titolazione del gioco: «Luca
scusami ma ti ricordi il titolo di quel gioco dove stavano i nemici incappucciati e uno
che sparava tipo 007?», «sì, ma non te lo dirò mai». I più esperti
utilizzatori di Rolling Thunder facevano ricorso al trucco del torno indietro perché
sono uomo di mondo e scopo, dal momento che ottenuta la prima infornata di munizioni
si può varcare la porta apposita per nuove ricariche formato mitra, e così per diverse
volte, tempo permettendo. Perché bisogna far presto, ché hanno rapito la nostra Leila e
chissà che le fanno, se non arriviamo.
Se la sparatoria gratifica l’immediatezza del gameplay,
ponderare l’utilizzo delle armi diverrà opportuno allorché vomitare proiettili senza
criterio porterà a capitolazione certa. Quindi una saggia ottimizzazione delle risorse
determinerà, quasi certamente, una buona qualità della vita nello stage delle iene
(erano iene?) e dei pupazzi di lava. Avremo comunque a disposizione una barra energetica
che potrà tollerare due “errori”, siano essi cagionati da un proiettile o dalla
semplice collisione con un nemico, un po’ come succedeva con l’armatura di Arthur in
Ghosts’n
Goblins. Il ritmo sostenuto non concede zone morte e questo condanna il manovrante a
uno stato di apprensione perpetua in prossimità delle porte, poiché ben sai che queste
tendono a spalancarsi. A vomitare scagnozzi. La questione longevità, in un videogioco
rigido qual è Rolling Thunder, è un fatto soggettivo. Imparare la disposizione di nemici
consentirà, dopo un discreto training, di giungere agli stage avanzati
ricorrendo a giusto un paio di endovenose di adrenalina. Ma anche sotto narcosi dubitiamo
sulla effettiva volontà del videogiocatore di ripetere lo stage dal principio in caso di
morte accidentale, in territorio ultimo livello, quando già si pensa a stappare lo champagne
e si è con la testa alla cerimonia del trionfo, nel post-sala, con gli amici muniti
di assegno settimanale di Lire 1000 a raccogliere gli schizzi. D’altra parte siamo nell’Ottantasei. Non puoi mica chiedere a Namco di limitare il discorso della frustrazione.
Visivamente siamo su buonissimi livelli. Risulta
particolarmente apprezzabile il design degli sprite, assai caratterizzati e animati in
ottimo stile nel caso dei monumentali cattivi tipo ku klux klan verde e blu, ma anche
viola, e funzionante l’intera architettura a scale e blocchi, a circoscrivere l’ambiente e
determinare il cliché della tana del nemico che ti attende al varco col trucco, ché non
puoi che perdere la vita quando la bomba ti arriva improvvisa, da sopra. Seppure fisso nel
tracciare una geografia chiusa e cromaticamente lineare, Rolling Thunder realizza nel
minimalismo delle grafiche la sua virtù essenziale, ché ancora si rammentano quei luoghi
di pilastri grigi e pareti verdi, di mostri gialli e mostri blu, di sotterranei fatti
apposta a preludio della perdita della vita extra che s’era guadagnata versando sangue.
L’accompagnamento musicale è atroce. Ma non in senso necessariamente dispregiativo, ma
proprio per via della ridondanza (atto intenzionale della cattivissima Namco degli anni
Ottanta), per via di questo motivo che si ripete all’infinito e che vorresti che smettesse
di ripetersi all’infinito, ché ti entra nel cervello il motivo e va a finire che a
scuola, il giorno dopo, non senti che quel motivo durante l’interrogazione di italiano.
Gli effetti sonori restano nella media delle produzioni appartenenti a quel periodo. Ché
i microchip audio erano quello che erano, in quel periodo. Ora sì, estetica. Eppure il
fattore predominante, quello che incide sul destino del titolo, s’appresta col tarlo della
fruizione compulsiva, appresso la necessità di doversi torturare anche dopo aver speso
fior di gettoni e aver compreso che, probabilmente, sarà il banco a prendersi tutto.

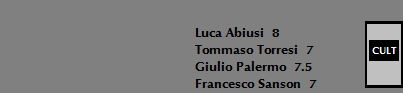
|
|


