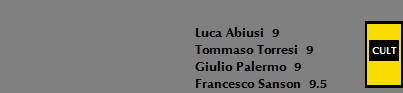Fumito
Ueda permettendo, la figura comunemente resa del game designer che si realizza
il videogioco in assolo può dirsi definitivamente estinta. Si è per questo
ripreso Prince of Persia, il gioco in capture
di Jordan Mechner che viene scritto su di un pezzo da museo
– e lo era già allora – come l’Apple II; si è ritrovata la coerenza strutturale
cui questi listati di bidimensione pura dovevano attenersi, nel
periodo di fine Ottanta che vede l’inizio della ridefinizione del mercato
occidentale, dopo l’impasse della Atari. Si è ripercorsa la rivoluzione del
Principe di Persia, quest’avventura che assume lo spessore dell’arcano più
in su della tradizione del linearismo e oltre le convenzioni dell’action
game per undicenni, dodicenni generati in provetta da Nintendo e immessi
come alieni bimbiminkia capaci di conquistare il mondo. Prince of Persia è
oggetto che rivendica la cultura neoclassica (nonché caucasica) del
platformismo. Saltare sì, ma ispezionare e pensare anche, e poi confluire
nella antologia, essere profeti del videogioco che verrà.
Fumito
Ueda permettendo, la figura comunemente resa del game designer che si realizza
il videogioco in assolo può dirsi definitivamente estinta. Si è per questo
ripreso Prince of Persia, il gioco in capture
di Jordan Mechner che viene scritto su di un pezzo da museo
– e lo era già allora – come l’Apple II; si è ritrovata la coerenza strutturale
cui questi listati di bidimensione pura dovevano attenersi, nel
periodo di fine Ottanta che vede l’inizio della ridefinizione del mercato
occidentale, dopo l’impasse della Atari. Si è ripercorsa la rivoluzione del
Principe di Persia, quest’avventura che assume lo spessore dell’arcano più
in su della tradizione del linearismo e oltre le convenzioni dell’action
game per undicenni, dodicenni generati in provetta da Nintendo e immessi
come alieni bimbiminkia capaci di conquistare il mondo. Prince of Persia è
oggetto che rivendica la cultura neoclassica (nonché caucasica) del
platformismo. Saltare sì, ma ispezionare e pensare anche, e poi confluire
nella antologia, essere profeti del videogioco che verrà.
Prince of Persia vuol essere smisurato. Così
le estetiche di apparente spartanità effondono il metodo, la ricerca della visione
schematizzata ed elementare, per catturare l’immaginazione di chi osserva già
dall’ingresso nelle segrete. Essenzialmente, l’intero gioco ruota attorno al carisma del
nostro alter ego. Questi si anima concatenando un indicibile numero di frame attraverso la
tecnica del rotoscope; le sinuose movenze del principe realizzano istantanee
il solco tra il
già dato di una animazione di secondaria importanza e un futuro prossimo che avrebbe visto
la creazione di monumenti al motion capture quali sono i
protagonisti di
Another World e
Flashback. Il videogioco: è tutt’ora ammirevole la
fluidità empirica cui il principino produce i movimenti del caso: lo si vedrà
correre, rimanere appeso e dondolare sui cornicioni, perdere l’equilibrio sull’orlo di un
precipizio, afferrare il bordo di una piattaforma dopo un poderoso salto da una altura,
cadere e spiaccicarsi al suolo, oppure essere tagliuzzato da lame meccaniche o infilzato
dalle trappole a pungiglione sparse un po’ ovunque. La occorsa immedesimazione alla
avventura è allora il sintomo di questo character design ingegnoso come i
meccanismi di sbloccaggio, gli scheletri che si ricompongono per sfidarci in singolar
tenzone. Tenendo il pulsante premuto e applicando la direzione il nostro si muove
furtivo, lento per passare attraverso gli spuntoni. Le piattaforme sono instabili. Succede
che il pavimento ceda al peso e che si precipiti al piano inferiore, ove
possibilmente vi è una qualche diavoleria a leva che blocca i cancelli e che quindi
sbarra il passaggio al prossimo schermo.
Il rigore della regia, della messa in scena, finisce per
coinvolgere. Mechner ha il talento di mettere in opera una struttura dinamica e riflessiva
al contempo, un arcade adventure anomalo che non concede punti di riferimento. La
missione del gameplay vira sul bordo dell’interagibile, determina il puro
arcade dei combattimenti all’arma bianca e di nuovo dispone i fondamenti del puzzle game
levigato, nelle sezioni volgenti l’esplorazione. Si avvertirà il
sudaticcio, sulle dita, quando si balzerà di piattaforma da zone
soprelevate, con il solo vuoto a preservare da una morte atroce o a
concedere la salvezza, estemporanea, per fare il prosieguo verso la
scrittura di variazione, il dinamismo. Tutto è subordinato al
tempismo: visto che per concludere e quindi salvare la nostra amata vien concessa una sola ora, l’odissea
verrà consumandosi nell’ansia di non poter sbagliare, di dover affrontare
presto una considerevole quantità di schermi per poi cogliere, alla fine, il
motivo dell’interconnessione degli spazi. Questo è Prince of Persia. Anche
nella traduzione Amiga. Che, grazie al cielo, tiene fede alla opera prima –
ciò che non sarebbe accaduto con le successive edizioni console – nella replicazione
essenziale dei colori e nella caratterizzazione del principe. Sebbene il dettaglio risulti
sensibilmente potenziato in rapporto all’Apple II, i realizzatori esterni si sono
scrupolosamente attenuti alla claustrofobia mechneriana, di fatto creando una versione
suppletiva e non sostitutiva dell’originale. Gli effetti sonori, generalmente campionati,
risultano assai verosimili – qui sì che si avverte il passaggio a tecnologie superiori
–
ma pur sempre innescati a una attenta lettura dell’ambiente per non pregiudicare il senso
di chiuso e i labirinti. I sotterranei inestricabili.