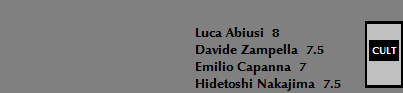Ci
atteniamo a un
Osamu Dezaki sproloquiante, al battere delle una e un
quarto di una notte settantesca, tabacco fumante nel quadrato quattro metri per
quattro in cui Akio Sugino, che tutto incurvo sul disegno si era fatto
persuadere all’intervallo-carta Kodak marcante stretto l’espediente della
rievocazione con gesto annuente gli rende presenza; son rimasti ventiquattro ore
su questo cinema d’animazione di ombreggiature superlative, che per loro non
doveva essere una cosa per cui venire a ricompensa ma luogo di accesso a un
drammatismo rigorosamente confidenziale, di storie scolastiche
che servono a temprare lo spirito. E le ossa. Il corrispettivo cinematografico di Jenny la tennista (Ace
wo Nerae!) è un testo motivante, Mabushii Kisetsu ni, da cantarsi quando
nessuno sente, e che onestamente non poteva orientarsi più allusivo e
caratterizzante, anima stessa di un anime che prescrive il
sentimento umano e mica solo l’amore filmico soltanto, ché il dezakismo
suggerisce la traspositura di un cifrario nichilistico deviato
all’introvertente, come se dello svestimento dell’io fanciullo, tra gli
ostacoli del puntare all’ace, al successo, e a un domani dal quale non si
ricavasse sconto.
Ci
atteniamo a un
Osamu Dezaki sproloquiante, al battere delle una e un
quarto di una notte settantesca, tabacco fumante nel quadrato quattro metri per
quattro in cui Akio Sugino, che tutto incurvo sul disegno si era fatto
persuadere all’intervallo-carta Kodak marcante stretto l’espediente della
rievocazione con gesto annuente gli rende presenza; son rimasti ventiquattro ore
su questo cinema d’animazione di ombreggiature superlative, che per loro non
doveva essere una cosa per cui venire a ricompensa ma luogo di accesso a un
drammatismo rigorosamente confidenziale, di storie scolastiche
che servono a temprare lo spirito. E le ossa. Il corrispettivo cinematografico di Jenny la tennista (Ace
wo Nerae!) è un testo motivante, Mabushii Kisetsu ni, da cantarsi quando
nessuno sente, e che onestamente non poteva orientarsi più allusivo e
caratterizzante, anima stessa di un anime che prescrive il
sentimento umano e mica solo l’amore filmico soltanto, ché il dezakismo
suggerisce la traspositura di un cifrario nichilistico deviato
all’introvertente, come se dello svestimento dell’io fanciullo, tra gli
ostacoli del puntare all’ace, al successo, e a un domani dal quale non si
ricavasse sconto.
Sul meccanismo dell’arredo emotivo – sennonché
coevo a una indagine messa in moto su qualcuna panoramica di libeccio, nell’urbanismo
delle zone portuali, e al calcificarsi
di un colore che riacquista il punto luce dalle geografie di staticità, sino a un ricalco
anatomico da schierare a continuatura del
perimetro campestre – si esibisce il
riuso del fotogramma ch’era stato inserito nella serie televisiva, per vederlo
confondersi a materiali di split screen individuabili in un qual girato di
Fernando Di Leo presso cui si maneggiavano le pistole, e si davano gli schiaffoni
alle femmine in anticipo sulla forzura obliqua di un
Golgo 13: The
Professional; il drama della mimica aerodinamica e dei profili
perfetti, quanto di un cospicuo numero di corpure elastiche e irricreabili si deve attribuire a
Dezaki. E imputare a Sugino, immediatamente dopo. Sennon dove che è
l’interazione tra questi a garantire, allo stato chimico, sul rigore di certe
elevatissime posture e squadramenti chic di mezzi volti, messe a fuoco smaltate,
scassinamenti di proporzioni e prospettive che trasducono all’animazione il
controluce del verniciato extralucido, ai sensi di un complesso di elementi
estrogeni e principeschi, nel quarzo di questi occhi azzurri grandi che se li
fissi ti ci specchi dentro, e ti ci perdi.
Si vede che l’idea politica che identifica il film
si ispira al feudalesimo, riteniamo a una retorica di rigido formalismo e nondiché
a una base di interlocutori giovine abbastanza da avere ereditati i dogmi della rifondazione post-bellica,
e nienteché un
modello patriarcale di ubbidienza e rispetto delle linee gerarchiche sociali che
portasse a sostenere talune mentali tecniche di circuizione, e che
prevedesse allora accurate sessioni di servizi scagliati a duecentocinquanta
chilometri orari contro i temerari addomi delle fanciulle, perché potessero
crescer forti e figliare i futuri capigruppo del Nippon Ishin no Kai (日本維新の会).
Sapete
cosa: ci hanno preso a sufficienza. Ché il Giappone degli ultimi anni ’70 chiede
l’arrampicamento di classe, e conviene con le pratiche dell’abuso usato per
intercedere ai prioristi umani limiti, se ancora di mezzo al gesto passionevole
e a prassi di una tensione melodrammatica che si contraesse a stato febbrile, un
presentimento uno sbalzo emozionale, l’accettazione dell’inclemenza e la
percezione di un anelito di rivalsa. Che non sta a dire che la oratoria
educazionale di Ace wo Nerae!, sebbene sempre filo-borghese, non si adopri a un
portamento veristico di fine integrità, sul graticcio del racconto
post-neorealista d’autore e che non riveli, con franchezza e smuovendo i tasti
sensibili all’orgoglio razziale giapponese un resistenzismo a grandi linee
giusto, che miete riscontro nel moderno vissuto.