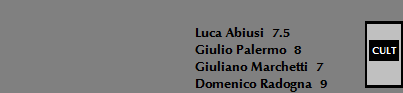Si
è veduti collettori che arroccavano sulla convinzione che l’anime
sarebbe un luogo dal quale non è concepibile fuoriuscire, e si è poi uditi i
medesimi di cui sopra seguitare sulle deliranti teorie che vedrebbero la razza
giapponese discendere dagli dei e in diritto di rivendicare superiorità di
sangue difronte al bastardo gaijin. Solo che Rintaro e Ôtomo Katsuhiro, che
a ben motivo esibirebbero linee di discendenza diretta col Divino Izanagi, devono
pensarla in modo radicalmente diverso acclarati i fatti del 2001, lì quando li
si è visti dare asilo a Metropolis
e ricuperare l’animazione di Harman e Ising, che negli anni ’30 avevano ideato
cortometraggi in Technicolor per insidiare Walt Disney e inquietare donne,
vecchi e bambini, ché
diciamocelo, quei disegni trasmettevano un nonsoché di spaventevole ogni qual
volta ti capitasse di guardarne uno, su Rai Uno, a motivo di un lineamento che ti precipitava nel grottesco; eppure, la fluidità della cel
animation di Happy Harmonies doveva essere il punto da cui partire
alla retribuzione dell’opera di Tezuka, per troppo
tempo rimasta orfana di alcun riferimento cinematografico.
Si
è veduti collettori che arroccavano sulla convinzione che l’anime
sarebbe un luogo dal quale non è concepibile fuoriuscire, e si è poi uditi i
medesimi di cui sopra seguitare sulle deliranti teorie che vedrebbero la razza
giapponese discendere dagli dei e in diritto di rivendicare superiorità di
sangue difronte al bastardo gaijin. Solo che Rintaro e Ôtomo Katsuhiro, che
a ben motivo esibirebbero linee di discendenza diretta col Divino Izanagi, devono
pensarla in modo radicalmente diverso acclarati i fatti del 2001, lì quando li
si è visti dare asilo a Metropolis
e ricuperare l’animazione di Harman e Ising, che negli anni ’30 avevano ideato
cortometraggi in Technicolor per insidiare Walt Disney e inquietare donne,
vecchi e bambini, ché
diciamocelo, quei disegni trasmettevano un nonsoché di spaventevole ogni qual
volta ti capitasse di guardarne uno, su Rai Uno, a motivo di un lineamento che ti precipitava nel grottesco; eppure, la fluidità della cel
animation di Happy Harmonies doveva essere il punto da cui partire
alla retribuzione dell’opera di Tezuka, per troppo
tempo rimasta orfana di alcun riferimento cinematografico.
Addossandosi il rischio della licenza visiva, e di
certo in accordo col character design di Yasuhiro Nakura e gli addetti
alle grafiche renderizzate, Rintaro si spinge a toccare una sua ultima visione
della “città-Stato” e delle sue gerarchie, qualora a confronto coi volumi
sorgenti e da un lato figurativo, e semmai sui temi generali da
tribuire alle righe scritte, prima di cedere arbitrio a un Ôtomo qui operante in
veste di sceneggiatore, che anche porta avanti, su di un canale parallelo, tanto di
script e regia per
Steamboy; il dilemma
sulla cognizione dell’identità umanoide e del suo ridursi a ferraglia di
scarto viene in Metropolis affrontato seguendo il criterio delle leggi di Asimov
in una biblica Ziggurat dal cui apogeo dominare il mondo. E diventa, questa
imponente arma di distruzione, vettore di stravolgimenti di casta che non si è in grado di presentire
pure nel dubbio legittimo secondo
cui, il robot, potrebbe in effetti non bisognare dei servigi dell’uomo, allorché l’intelligenza artificiale, in coscienza di sé, venisse
interconnessa all’estremità del cannone. Ovvero il mezzo attraverso il quale, in
linea teorica, si doveva sancire la supremazia dell’«io» biologico sull’«io»
sintetico. La figura dell’androide Tima sviluppa in definitiva le teorie
sull’inviolabilità dell’anima, che quand’anche derubata del “guscio” – il
regista elabora e fa sue le idee trascendenti di Mamoru Oshii – dietro impianto
extracorporeo continua a declarare la sua essenza.
Il film ricorre all’uso di una incalcolabile
quantità di materiale concettuale a fronte della esigenza di sovraesporre il
luogo proteso in altezza, e se ne osserveranno le scalature dallo scuro allo
schiarire, sul riverbero di luce che obliquamente filtra in profondità
dall’apertura degli impalcamenti; in diverse occasioni, e in principal modo
nelle manovre di anti-zoom che dischiudono il campo lungo, si opzionano
integrative tecniche di precalcolo in CG in vernice fresca, da invocazione del
regista, che in seguito dirà che «Metropolis, film quasi unicamente costruito da
fotogrammi disegnati a mano, fa uso del calcolo tridimensionale lì dove
l’animazione classica non avrebbe modo di arrivare». Ed è vero, ma solo in
parte. Non si è in grado di produrre cartacei che sconfessino quanto da Rintaro
dichiarato eppure un certo abuso della computeristica si ritroverebbe
nell’inquadratura che realizza il finale, dove l’aeroplano abbandona la Ziggurat
mediante una virata non tanto impossibile da riscrivere su rodovetro, ma si
parla di dettagli. Il limite (minore, ma avvistabile) a cui il film si presta
sui tre quarti di proiezione attiene la medesima verbosità che nell’85 aveva
oltremisura esteso il minutaggio de
La spada dei Kamui; il regista, colto da
giustificabili sensi di colpa circa il lavoro, inquantificabile, svolto da
intercalatori senza più una vita, e per non costringere al macero un quarto
d’ora di girato almeno conclude di dover preservare intermezzi che di norma
avrebbero dovuto rimanere fuori. Ma lo straordinario impatto visuale resta. Come
restano, intatti, i concetti della grande letteratura di fantascienza portati
nel dopoguerra da Osamu Tezuka. Il quale, ne siamo abbastanza convinti, avrebbe
finito per amare visceralmente il film di Rintaro.