|
STREET FIGHTER
di @Luca
Abiusi
 Anno ricco d’invenzioni
il 1987, nel campo dei videogiochi. In arcade erano usciti
Black Tiger e
Rainbow
Islands facendo clamore ma nessuno osò immaginarsi quel che sarebbe
accaduto
cinque minuti dopo nel Palladium, quando che installarono il cassone di Street Fighter,
pestatore a incontri dove si vestivano i panni di Ryu, un karateka senza macchia
arruolatosi
contro i più temibili combattenti del globo. Nessuno aveva nemmeno provato a
ipotizzare la rivoluzione
dell’idea di questi lottatori statuari realisticamente animati, di grafiche dal
dettaglio impensabile, ’sti fondali che disegnano luoghi urbani e muraglie cinesi, di prove
di abilità a spaccare i blocchi dei mattoni, in mezzo a folle di spettatori, tra un
livello e l’altro. Il genere del picchiaduro a scorrimento, che grazie a Technos
poteva ancora esercitare il suo fascino tra gli astanti di metà anni Ottanta, inizia a
piegarsi a tale spettacoloso tirare di palle di fuoco e di calci multipli, che
sono ancora adesso mosse-manifesto con tutti gli episodi che la saga ha nel
corso dei decenni generato. Anno ricco d’invenzioni
il 1987, nel campo dei videogiochi. In arcade erano usciti
Black Tiger e
Rainbow
Islands facendo clamore ma nessuno osò immaginarsi quel che sarebbe
accaduto
cinque minuti dopo nel Palladium, quando che installarono il cassone di Street Fighter,
pestatore a incontri dove si vestivano i panni di Ryu, un karateka senza macchia
arruolatosi
contro i più temibili combattenti del globo. Nessuno aveva nemmeno provato a
ipotizzare la rivoluzione
dell’idea di questi lottatori statuari realisticamente animati, di grafiche dal
dettaglio impensabile, ’sti fondali che disegnano luoghi urbani e muraglie cinesi, di prove
di abilità a spaccare i blocchi dei mattoni, in mezzo a folle di spettatori, tra un
livello e l’altro. Il genere del picchiaduro a scorrimento, che grazie a Technos
poteva ancora esercitare il suo fascino tra gli astanti di metà anni Ottanta, inizia a
piegarsi a tale spettacoloso tirare di palle di fuoco e di calci multipli, che
sono ancora adesso mosse-manifesto con tutti gli episodi che la saga ha nel
corso dei decenni generato.
Street Fighter era diverso. Prima che
il beat ’em up Capcom irrompesse, il metro di riferimento per il
genere poteva essere Double
Dragon, ché fu Capcom a inventare la meccanica a incontri focalizzando il
combattimento tra due lottatori, inquadrati in una schermata che pure nello scrolling
tenesse i margini ben delimitati; il dovere combattere dentro a un’area di gioco
ristretta
portava dunque a considerare il picchiaduro come a un surrogato marziale
approfondibile, datoché il fine ultimo non era più quello di superare il
quadro, ma bensì di scoprire le mosse. Il che ci porta alla questione basilare delle fireball. Eseguire le
combinazioni a mezza
luna per poi vedere realizzate le sfere infuocate era il motivo del gameplay, il
virtuosismo da svelare a quelli che stavano dietro, che non le sapevano fare; poi c’era lo
shoryuken, l’uppercut da realizzare in avvicinamento che sottrae più delle
fireball che se riesci a eseguire puoi tutto. Anche prenderti le chiavi
della sala. I comandi rispondevano con un ritardo
allarmante ma alla fine importava relativamente, dal momento che l’obiettivo era
di fare del male al joystick, oltre che all’opponente, in questa epoca di rivoluzioni in cui
il “lag” non si sapeva che cosa fosse e ci si concedeva al cabinato a due
schermi come
all’invenzione definitiva da portare alle tecnologie a tubo catodico.
C’erano questi bambini ciccioni che
reclamavano posizione quando Noi si era in difficoltà al quadro del punk, e
potevi al più allontanarli sferrando loro dei calci laterali. Ma poi si
spostavano, e continuavano. Sono cliché che fanno storia e che sono parte
del contesto cui Street Fighter prestava i suoi servigi di pestatore uno contro uno pieno
di trucchi e bugs a cui attingere se davvero si vuole ultimare, benché ultimare fosse
una chimera, con quel boss tailandese che faceva paura solo a vederlo. Però si poteva
quantomeno arrivare al penultimo stage accumulando esperienza e innalzando
il grado di attenzione
quando a occupare il coin-op erano i veterani, quelli che vivevano in sala e che avevano
messo su famiglia vicino al cassone di Tehkan World Cup con un secondo giocatore
simile a una donna, che non poteva di certo possedere la vagina nell’Ottantasette, il
secondo giocatore, in una sala giochi. Quindi scoprivi che nel quadro del Monte Rushmore
era sufficiente colpire Mike con un pugno e mettersi in parata in una estremità, ché
tanto il negrone era un automa. E con ciò Street Fighter resta il precursore di TUTTI i
picchiaduro moderni, il prototipo del videogioco a combattimento, il seme di una
evoluzione che ci ha portati a titoli quali SoulCalibur e
Marvel vs Capcom 2.
Non sappiamo fino a che punto Street Fighter sia definibile videogioco di
culto, ma si è abbastanza sicuri che il prestigio della Capcom attuale è riconducibile ai
fatti del 1987.

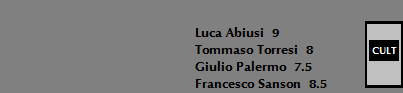
|
|


