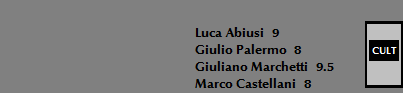Se
provassi a oltrepassare quest’idea dove i film devono conservare un principio e una fine, e
opzionassi una dimensione di metà Novecento in cui dibattere con Truffaut e
Godard nel merito della possibilità di estrarre dagli archivi maledetti della
Cinémathèque Française un cinema di multiangolare scansione di sé stesso, potresti magari trovarti in obbligo di conciliare la settima
arte all’evocazione dello spirito di Satoshi Kon. Che nel 2001 aveva diretto il
presente Millennium Actress come un trompe-l’œil che fornisse nuova
versione dietro altrettanta visione, poiché il tributo nei confronti della
trasformabilità delle immagini cinematografiche doveva comportare di queste
il riposizionamento in misura di frammenti tridimensionali. Che avrebbero dovuto dar luogo al flusso cinetico,
onde svilupparsi secondo i criteri del cartonato delle opere teatrali
itineranti: si allestiva un orizzonte artificiale oppure due, in funzione dell’ondulamento del mare, e un paio di addetti alle estremità del palcoscenico che
in fasi alterne muovessero. Il risultato poteva
convincere sebbene si notasse bene che era un trucco. Eppure, si era
disposti a pensare che sì tanta finzione non avesse che da restituire le sue
teoretiche verità, foss’anche a un astante disorientato dall’incoerenza dei
luoghi e dei tempi, rispetto a precedenti e più formali tecniche di
contravvenzione visiva.
Se
provassi a oltrepassare quest’idea dove i film devono conservare un principio e una fine, e
opzionassi una dimensione di metà Novecento in cui dibattere con Truffaut e
Godard nel merito della possibilità di estrarre dagli archivi maledetti della
Cinémathèque Française un cinema di multiangolare scansione di sé stesso, potresti magari trovarti in obbligo di conciliare la settima
arte all’evocazione dello spirito di Satoshi Kon. Che nel 2001 aveva diretto il
presente Millennium Actress come un trompe-l’œil che fornisse nuova
versione dietro altrettanta visione, poiché il tributo nei confronti della
trasformabilità delle immagini cinematografiche doveva comportare di queste
il riposizionamento in misura di frammenti tridimensionali. Che avrebbero dovuto dar luogo al flusso cinetico,
onde svilupparsi secondo i criteri del cartonato delle opere teatrali
itineranti: si allestiva un orizzonte artificiale oppure due, in funzione dell’ondulamento del mare, e un paio di addetti alle estremità del palcoscenico che
in fasi alterne muovessero. Il risultato poteva
convincere sebbene si notasse bene che era un trucco. Eppure, si era
disposti a pensare che sì tanta finzione non avesse che da restituire le sue
teoretiche verità, foss’anche a un astante disorientato dall’incoerenza dei
luoghi e dei tempi, rispetto a precedenti e più formali tecniche di
contravvenzione visiva.
L’itinerario del resoconto storico e della storia
del cinema giapponese, a loro volta ripresi dalla videocamera di un
documentarista che i film dell’«attrice del millennio» sembra che se li è visti
cinquantaquattro volte addestra, accostando il picture in
picture, in un diversivo che dal riverire Chiyoko Fujiwara – monumento
(vivente) alla memoria di Ginei Studios – passa al montare di un “instant
colossal” di cui essere modificatori in terra straniera, in Manciuria per
retrocedere a cavallo al periodo Edo a fare da scudo alla principessa fino a
condurla in salvo tra le frecce e lo sgomento del secondo operatore, che d’un
tratto non sa dove si trova e deve anch’egli convincersi di dovere agire per non
farsi investire da situazioni più grandi di lui, in quanto il cinema vuol dire
mistificazione, e anche succedesse di sacrificarsi in sua vece pur malgrado
questo surrealista metodo Stanislavskij in virtù del quale improvvisarsi
registi, sceneggiatori, attori e direttori della fotografia non vi è di sollevar
questione, ché si chiedeva giusto di rimanere dentro la messinscena e vedere di
riuscire a identificare il colpevole, quello che era fuggito dal set di
Perfect Blue non
lasciando traccia di sé. Il funzionario governativo che fa imprigionare l’unica
persona che Chiyoko diceva di aver amato è sinistro abbastanza da rispondere ai
requisiti di ricerca, sempreché codesto amante esistesse per davvero, che lo si è
visto nel film, mica nella realtà. A meno che non fosse vero il contrario. E Satoshi Kon vince.
Per la
seconda volta.
Millennium Actress è uno straziante, disperato
atto di purificazione del modello cinematografico precedente al digitale. E non
stiamo tuttavia dicendo di un film che debba onanisticamente dimostrarsi a una
cinefilia d’elite e appagare certune aristocrazie addentrabili mediante stretto
giro di conoscenze nei dintorni veneziani o nei circoli clandestini di Montreal.
Quantomeno non
solo, essendoché il film persegue tra le sue biforcazioni decifrative uno
svolgimento melancolico accedibile, dell’amore destinato a rimanere sospeso, per
quanto stoicamente lo si alimenti, balzando di set in set, lanciandosi nello
spazio profondo poiché «dopotutto, è il fatto d’inseguirlo ciò che amo davvero»;
la resa drammatica, inesorabile del teleromanzo “epocale” va conseguendo
liricamente il suo acuto nel sottintendere, in una manovra allegorica
riguardante il legame sottile tra metanarrazione e significato risposto, che le
surrogate stazioni del vissuto (e agognato) non sono che parti di uno
script, assegnazioni di ruoli che serviranno a illudere chi li interpreta di
poter avanzare l’ultima parola sul finale. Che però è già stato deciso. Satoshi
Kon, elegantissimo, nondimeno impegnato sui due fronti della regia e del
character design induce quest’arte manuale di trasformismo scenografico a
rivestitura del sontuoso scritto di Sadayuki Murai – autore eterogeneo: nel
2004 avrebbe co-sceneggiato
Steamboy e ciò nonostante ottenuto, nei successivi anni, copioni di
rilevanza minore – e a investitura di lessicologie consuete a sparuti altri.