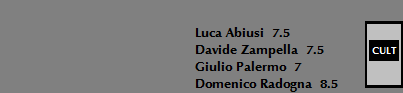Si
potrebbe semplificare e dire che il terzo Satoshi Kon se ne va da un’altra
parte, e ma possiamo giurare sullo spirito del Natale presente che ciò è vero
nemmeno a volerlo pensare soltanto, da che lo sapete voi per primi che
s’incomincia dal racconto invernale e si arriva in un intermedio in cui doversi
inventare storie d’incastri temporali rassomiglianti a novelle, con tutto il
rispetto per queste ultime, e ma Dio non voglia d’invischiarsi nella trappola
del sentimentalismo sfuso, ché davanti a Tokyo Godfathers si è disposto un testo che non
ti consente di mancare il singolo episodio rivelatore di certi fotogrammi
alternativi, quelli che porteranno uno dei tre disperati a rimanere sulle
strisce pedonali di una mezza frazione di secondo in più necessaria a eludere la
collisione con un motociclo fuori controllo. Per non parlare dell’ambulanza. Si
farà in modo di retrocedere al preciso istante in
cui il continuum viene deviato dal ritrovamento di questa bambina la cui
aura sembra volere alterare il destino di coloro che le si avvicinano.
Si
potrebbe semplificare e dire che il terzo Satoshi Kon se ne va da un’altra
parte, e ma possiamo giurare sullo spirito del Natale presente che ciò è vero
nemmeno a volerlo pensare soltanto, da che lo sapete voi per primi che
s’incomincia dal racconto invernale e si arriva in un intermedio in cui doversi
inventare storie d’incastri temporali rassomiglianti a novelle, con tutto il
rispetto per queste ultime, e ma Dio non voglia d’invischiarsi nella trappola
del sentimentalismo sfuso, ché davanti a Tokyo Godfathers si è disposto un testo che non
ti consente di mancare il singolo episodio rivelatore di certi fotogrammi
alternativi, quelli che porteranno uno dei tre disperati a rimanere sulle
strisce pedonali di una mezza frazione di secondo in più necessaria a eludere la
collisione con un motociclo fuori controllo. Per non parlare dell’ambulanza. Si
farà in modo di retrocedere al preciso istante in
cui il continuum viene deviato dal ritrovamento di questa bambina la cui
aura sembra volere alterare il destino di coloro che le si avvicinano.
Che a concertare il film è stato Satoshi Kon lo
si determina da come abilmente venga esautorata la possibile controindicazione
della convenzionalità, presi in carico i ritornanti temi dell’abbandono, dell’intolleranza e
della vaga omofobia da scomodarsi nientemeno che alla natività del Cristo, dove si è tutti più
buoni e dove invece in realtà si è tutti cattivi, ancor meglio se in questo
Giappone tutto ordinato e rispettoso, ma che se vede un senzatetto lo pesta rispettosamente a
sangue. «Kumbaya my Lord, Kumbaya», sembra il regista provocatoriamente
canticchiare pur senza sviare il binario della causalità rigorosa, aritmetica
(aritmica) della macchina consequenziale che dispone l’apparente disordine
nell’ordine prestabilito delle azioni che generano la struttura del caos,
l’uno e lo zero, traccia discontinua che nonostante le interruzioni di
assetto culmini sempre in un disegno “alto” che sia di ricerca, se non di
redenzione, di un equilibrio spirituale apocrifo e pagano, ché non dev’essere il
fondamento religioso a essere giusto, costui che dimora nell’oratoria delle
prediche e delle parabole e che, in accordo con la scena di apertura, se ne sta
al sicuro nelle chiese. Il “miracolo al quartiere commerciale di Shinjuku” ha a
che fare con l’improbabile legame, eppure totalmente autentico, che cementifica
tra gli emarginati in lotta per la sopravvivenza, in questo caso altresì custodi
designati del nuovo nato. Tokyo Godfathers sovviene a forma di commedia
sofisticata, pungente nella migliore tradizione del bianco e nero
all’americana.
Si è riversato sul colore uno strato di cloruro
di sodio che ne aumentasse il composto, e che vedesse riconsegnati ai corpi
equivalenti motivi di soffusione, per iniezioni di luci che sanno risaltare le linee corrugali di media
caricatura, perché s’inscenasse uno spettacolo di “macchiette” in cui
occasionalmente far prevalere la
dismisura delle sezioni anatomiche inferiori – la deambulazione di certi momenti
secondari diventa di mero accenno, quasi che il regista intendesse attenuare col
teatro mimetico il verismo periferico della quotidianità – a intercedere a
un’arguto sense of humor che è di postura, oltreché di recitazione e
stringhe di battute da pronunziarsi sul controtempo cinematico, che da
Millennium Actress in avanti non si scompone, qui reggendo il dilatarsi della forma
costruttiva (discorsiva) altra persino nel quando si manifestino a schermo i
logotipi del dramma etnico-tradizionale, ancor dove nel Giappone non
propriamente multirazziale d’inizio anni Duemila. Tokyo Godfathers,
con le sue inverosimili coincidenze, rilegge il cinema del populismo e del lieto
fine alla maniera di Frank Capra, quello del significato postumo, amaro che
vorrebbe riportare al diretto contrario di quanto avviene in proiezione;
storditi dal finale improbabile, si resta sospesi tra la volontà di
conciliazione, di farsi coinvolgere dall’emotività degli “eventi soprannaturali”,
e la necessità di razionalizzare, per concludere che i miracoli succedono solo
nelle storie che si raccontano ai bambini per dire loro che va tutto bene. A un
certo punto, sulla colonna di un giornale, si nota un riferimento alle “Cham”,
il gruppo idol di Perfect Blue.