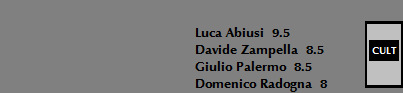Più
specificamente interessato alle sfumature fenomenologiche riguardo
l’attrazione dei giapponesi per le femmine che fanno le mossette che non al
fenomeno delle idol in sé, che si limiterà a riciclare per esigenze
divulgative anteriori,
Satoshi Kon, nel 1997, erige un labirinto attraverso cui poter espletare
libera facoltà di
seppuku;
gli strattoni alle fronde serviranno a procurarsi escoriazioni e dolore, e
questa luce bluastra proveniente da tergo altro non è che un crudele tentativo
di sviamento,
come a illudersi di poterlo risolvere per davvero, l’enigma della mente che ti
dice che potresti essere chi non pensavi di essere, e che vi è una vaga ipotesi
di aver creduto di vivere la vita di qualcun altro a causa di una specie di
sindrome da sdoppiamento della personalità. Ma diverrebbe quest’ultima una
conclusione sin troppo normalizzante per gli standard divulgativi/cognitivi del
regista, cui si dovrebbe conferire mandato di prelazione sulla ragione, ai suoi
occhi disutile e prevedibile quanto la linea di pensiero di quello che ha
diretto il
live action francese di City Hunter.
Più
specificamente interessato alle sfumature fenomenologiche riguardo
l’attrazione dei giapponesi per le femmine che fanno le mossette che non al
fenomeno delle idol in sé, che si limiterà a riciclare per esigenze
divulgative anteriori,
Satoshi Kon, nel 1997, erige un labirinto attraverso cui poter espletare
libera facoltà di
seppuku;
gli strattoni alle fronde serviranno a procurarsi escoriazioni e dolore, e
questa luce bluastra proveniente da tergo altro non è che un crudele tentativo
di sviamento,
come a illudersi di poterlo risolvere per davvero, l’enigma della mente che ti
dice che potresti essere chi non pensavi di essere, e che vi è una vaga ipotesi
di aver creduto di vivere la vita di qualcun altro a causa di una specie di
sindrome da sdoppiamento della personalità. Ma diverrebbe quest’ultima una
conclusione sin troppo normalizzante per gli standard divulgativi/cognitivi del
regista, cui si dovrebbe conferire mandato di prelazione sulla ragione, ai suoi
occhi disutile e prevedibile quanto la linea di pensiero di quello che ha
diretto il
live action francese di City Hunter.
Il Giappone di Satoshi Kon risolve cromature ad
alto candeggio, e contrasta al massimo, dovendosi ripulire del
residuo di grigio in rapporto a figure (femminee) che debbono mettersi a fuoco quando
appena scalate dallo sfondo alla posa fotografica; l’espediente, ugualmente reso
mediante due strati di metacinema almeno e pure anche non coinvolto nell’ordine
di stretta consecuzione qual si sarebbe profilato in
Millennium Actress,
decentralizza la cinepresa fino a svuotare le attrici della loro esteriorità,
all’incirca a volerne eradicare l’essenza sul tessuto cromatico superficiale e
farne affiorare l’oscurità borderline; l’estroversione (empirica) dei corpi
schiude verso il necrotico per deformarsi a simiglianza dello stalker che
spaventoso assume il terzo fascicolo d’indagine residente nel faldone dei casi
irrisolti, ma la cosa che atterrisce, e che di fatto instilla nel cliché
settario degli anime un ritratto di cinematografia nuova è che il
maniaco, il tizio che uccide, la figura che equivale il male incarnato
sembrerebbe rispondere ai lineamenti di colui che si ferma a guardare i balletti
della pop star Mima. Lo stesso seduto al cinema in quarta fila, spostato sulla
destra dove dicono è garantita una migior visuale, e che in seguito, del film, si è
comprato il Blu-ray. Vi è un che di provocatorio sul come il regista argomenti
l’escalation dell’omicidio (e delle visioni di violenza) manovrando lo zoom
della videocamera in un ridondante meccanismo di scatole cinesi e comunque, lui
che filma, e che usa confondersi tra i passanti, resta nella cerchia dei principali
indiziati.
Il criterio di cattura del volto è scientifico.
Hanno svolto un discreto lavoro di make-up per fornire contributo alla causa
della fornicazione. Lo spostamento della camera a spalla è un trattato di
chirurgia estetica: in destrezza insinua gli spazi richiusi a inseguire il
materializzarsi di sagome trasparenti che fomentano i terrori, che sembra che
hanno messo un assassino nascosto dietro la tenda della doccia, e non si ha neppure il tempo di accusare i primi sintomi del
delirium tremens che vedi che finzione e realtà iniziano a distrarsi al punto
di potersi sovrapporre sul divisore di confine a specchio, ricorrente, con tanto
di ossequi da versare alla bibliografia di De Palma (Le due sorelle) e omaggi da
retribuire col rigore del caso a Scorsese (Taxi Driver) durante la sequenza di
chiusura da consumarsi in macchina, al caso che ci si fosse illusi d’essersi
meritati un momento di stasi a seguito del supplizio inferto e ricevuto a incarico
d’incisioni profonde, schizzi di liquido rosso ad alta velocità dappertutto e
senso d’impotenza per il fatto di non poter esibire, dall’esterno, prove
razionali che coincidessero lo script all’eversione della montatura scenica;
professionalmente irriducibile, Satoshi Kon supervisiona allo sviluppo del film
dai titoli di testa fin dove i vincoli decisionali di regista e character
designer non gli avessero negato parola – i testi di sceneggiatura, scritti
da Sadayuki Murai partendo da un soggetto di Yoshikazu Takeuchi, erano tuttavia
abbastanza validi da non necessitare di revisionamento alcuno – ma non manca
l’occasione di suggerire un campionario di rumori adulterati che in qualche
forma scomunicasse il j-pop di “Angel of Love”, occorrente invero al conflitto
dissonante tra ossessione e innocenza, schizofrenia e disilluso ritorno al
reale.