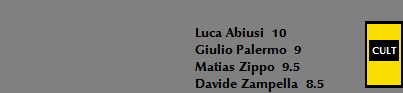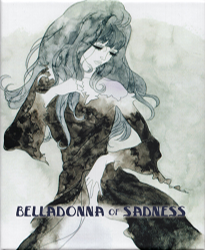 Nell’adeguamento cinematografico
del saggio di Jules Michelet “La Sorcière”
vi è deliberamente commesso ritratto di signora voluttuario; scurente posto a
schermo livido, sorta d’incubo proteiforme infestato di sagome di uccelli
neri, manieri, evoca palchi scenici Ningyō jōruri del secolo XVI
quanto che di revoche dell’animazione accademica e del contributo labiale, dove difatti è
solertata una recitatura vacante del suvvalore della deambulazione,
l’inerzia, il senso fluido dello spostamento costante;
Eiichi Yamamoto
pone in essere un partecipio di staticismo solo che apparente, lì che stabilisce
che il figurativo deve accedere l’inanimato pittorico, a torno di panoramiche di
feudalismi e stupri, di cui a scolture che si contingono di allucinazioni
scatologiche d’inferni viventi a protuberanze, falliche devianze delle coscienze
degli uomini, delle donne, le donne qui adesso astanti del ruolo più
significante, di avanti alle bugiardezze della storia dell’uomo, che le
ha rese drappeggi delle Signorie Loro.
Nell’adeguamento cinematografico
del saggio di Jules Michelet “La Sorcière”
vi è deliberamente commesso ritratto di signora voluttuario; scurente posto a
schermo livido, sorta d’incubo proteiforme infestato di sagome di uccelli
neri, manieri, evoca palchi scenici Ningyō jōruri del secolo XVI
quanto che di revoche dell’animazione accademica e del contributo labiale, dove difatti è
solertata una recitatura vacante del suvvalore della deambulazione,
l’inerzia, il senso fluido dello spostamento costante;
Eiichi Yamamoto
pone in essere un partecipio di staticismo solo che apparente, lì che stabilisce
che il figurativo deve accedere l’inanimato pittorico, a torno di panoramiche di
feudalismi e stupri, di cui a scolture che si contingono di allucinazioni
scatologiche d’inferni viventi a protuberanze, falliche devianze delle coscienze
degli uomini, delle donne, le donne qui adesso astanti del ruolo più
significante, di avanti alle bugiardezze della storia dell’uomo, che le
ha rese drappeggi delle Signorie Loro.
Kanashimi no Belladonna esegue incisure
mutilatrici dopo alle quali non si dovesse che penitenziare per tracimanze,
narrative di ematèmesi vorticanti verso l’immondo, tale se di un corpo che
disquami nel girone della ributtanza fuori a l’imperscrutabile trituramento dei
significati terreni, a che s’interdica il sacrario del decantato amore e si
dica anzi della librazione dai rituali cui sia detto esso artefice, è quindi verisimile che Yamamoto agisca in coda all’accademia linguistica di Osamu
Tezuka, il quale che aveva messo firma sull’eroticismo di Cleopatra e
Le mille e una Notte quando anche la ortografia di Belladonna racconta di assai altro
nell’attitudine a incrinare gli essudati verbali, nel che si verifica il
ribaltamento dei termini di sceneggiatura relativamente a un dato cinema
protocollare dei presti ’70, eccetto che per “I Diavoli” di Ken Russell, voto 9, di
poi a un esplicitario carniere cadevole a deformazione della cosa razionale, il
maligno che incurante del suo retaggio si concilia a colei che è perseguita,
come a volerle indicare la via, esserle da mentore di
una sessualità liberista e secessionaria fino in capo martirio; banalmente
astenico, il dio coscritto muove a titolo di concretazione del pensiero basico,
e non è buono né cattivo: lui, semplicemente, non esiste.
Kanashimi no Belladonna consegue fra tanto
visualismi di esasperazione delle orbite, al che pigmenta su cinque cròmi
primari che largano a guazzo nell’uso europeo di acquarelli a soggetto, di
ricorso ai frangenti della Wiener Sezession circa di un Richard Gerstl o il
chiatto minimalismo di Egon Schiele, ma per di più in grembo a una disegnistica
di calcinazione, superficienza, un
Kunimatsu Fukai
redigente su tela per
dereazione al dominante “divino”, a costo di ricognire punto a punto la curvezza
delle linee, i crani, zigomi qual si debbono dischiudere a fauci, vestigie di
bestialità sull’interluogo dell’omocentrismo; da un testo di Yoshiyuki Fukuda,
già scrittore per l’ibrido sunnaturale “The Vampire”, un esordiente, audace
tentativo di superponere strisce di animato a film live
action, Yamamoto induce ischemie catodico-psichedeliche contro di un tempo
registico surclassante i tempi, le classi, i
generi, i costumi del vivere in gratia Dei a vicinarsi alla mattanza
delle specie,
deumanizzando l’umano, di fronte a quella che può reputarsi una empirizzazione
aristotelica del surrealismo, e giuoca in sé incarichi di raffinatura dello stadio percettile questo
compositivo cerebrale, spirale di stonature con distonazione di scala Si bemolle maggiore, per cui ci si trova a
riverberare a vista per dentro
a mucillagini progressive rock inudite né ancora dallo scìbile contemplate.
In Giappone si limitarono a stampare il 45 giri delle canzoni di Mayumi
Tachibana. Nel 1975, tuttavia, Masahiko Satoh si fa incidere la colonna sonora
integrale dalla italiana Cinevox Record.