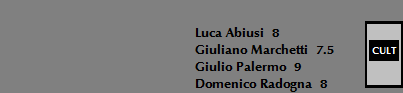Hiroyuki
Okiura manco era un regista. Si trovò a dirigere le animazioni per Zillion
e Record of Lodoss War,
fornendo manodopera allo storyboard di Ghost in the Shell, sul continuare del
’94, e dobbiamo supporre che il discorso dinastico della “Kerberos saga” dovette
risultargli oscuro nell’ambito del circondario di cospirazione che gli si
sarebbe parato davanti, malgrado che non si potesse dire di no a Oshii né tanto
ancora a queste sue ultime recrudescenze sul “dissacramento dell’ordine”, in
funzione delle quali muovere guerra al governo spia avanzante contro lo
stato di diritto, e prossimare una rivoluzione di controideologie che non
prevedessero eventualità di resa; nell’accordare al film l’algoritmo del
comportamento consequenziale di massa, Oshii ingaggia l’immanentismo di
certe opere di cui era stato primo responsabile – verrebbe su tutte di
menzionare il messianico
Patlabor 2: The Movie – delegando al “trascrivente” Okiura
piena discrezionalità creativa, al netto del contributo che lo stesso regista
avrebbe fornito alle tecniche visuali.
Hiroyuki
Okiura manco era un regista. Si trovò a dirigere le animazioni per Zillion
e Record of Lodoss War,
fornendo manodopera allo storyboard di Ghost in the Shell, sul continuare del
’94, e dobbiamo supporre che il discorso dinastico della “Kerberos saga” dovette
risultargli oscuro nell’ambito del circondario di cospirazione che gli si
sarebbe parato davanti, malgrado che non si potesse dire di no a Oshii né tanto
ancora a queste sue ultime recrudescenze sul “dissacramento dell’ordine”, in
funzione delle quali muovere guerra al governo spia avanzante contro lo
stato di diritto, e prossimare una rivoluzione di controideologie che non
prevedessero eventualità di resa; nell’accordare al film l’algoritmo del
comportamento consequenziale di massa, Oshii ingaggia l’immanentismo di
certe opere di cui era stato primo responsabile – verrebbe su tutte di
menzionare il messianico
Patlabor 2: The Movie – delegando al “trascrivente” Okiura
piena discrezionalità creativa, al netto del contributo che lo stesso regista
avrebbe fornito alle tecniche visuali.
Al narrato del rosso manto perduto nel bosco dovrà succedere di vedersela con epistoli di verismo ruvidissimo, a
seguito di breve rullaggio in diapositive e habitus evocativi e pur nonostante
il format del verbo grammaticale, chiaramente prolisso ma non tale da
perseguire la comprensibilità del contropolitico manifesto della sedizione; si propagherà di storie dove l’empio tende a venire divorato dal
lupo anche in caso che questi si fosse ricreduto in un misericordioso atto
compassionevole, contravvenendo il suo istinto, poiché sarebbe finito in ogni qual caso
nel dovere acconsentire di starsene in cima alla catena alimentare, e a non
detenere il potere di sovvertire le rigorose leggi della natura – umana, e quindi
animale – per pietās o ricorrente amore di una donna; la coesistenza
tra i generi, secondo Oshii, implica la predominanza del bisogno
nutrizionale sul culto della ragione, qui retrocesso a scienza inesatta per uso
del branco e a spese del timorato, colui il quale si ostina a credere
nell’esistenza di un’entità suprema che lo tragga in salvo presso i titoli di
coda. Ma non per Oshii. Che persuaso della irrazionalità del racconto a lieto fine,
di contro descrive un contesto sociopolitico caustico e paradigmatico ancora,
seppure adottando una dimensione storica non riferibile.
Okiura interdice il colore. Ne posterizza il tono in emulsione d’ocra di minimo pennello
e vermiglio spento, perché rassomigliasse a cinematografi in bianco e nero di
buon’ora stampati su piastre in 35 millimetri di grana visibile a occhio, a squamare
nel sentiero del neorealismo, e sin dietro una miscela d’immagini da cui far emergere l’inespiantabile voracità del darwinismo sociale; il
character design indistinto, languido, impone di riservarsi alle miscredenze dell’animazione,
già che l’anime
in quanto “prodotto” disfunzionale del Nuovo Impero Economico trabordava
nell’eccidio delle corporature, sistemi che venivano scarnificati a vantaggio
dell’ipertroficità dei volti, e di forme che dovevano esasperarsi e
sessualizzarsi per riempire i vuoti rimasti al dattiloscritto. Nel merito,
Jin-Roh è l’insubordinazione delle retrovie pensanti. L’impalcamento del suono
trova di che consistere a chiosa delle cineprese che si concentrano sui momenti
più disgregativi, che ai due estuari del film deliberano sul disingannevole
identificarsi a uno statuto “di fede”, e proprio nel quando il misticismo
scurisce nell’epistassi, mettendo fine alla speranza. Jin-Roh è opera i cui
plasmociti chiedono di rigettare chiunque vi trovi nuovi motivi di
riaccosto, e abbiamo Noi stessi dovuto resistere a un passante richiamo di
conservazione prima di ritornare a questo film così inesorabile, alto monumento
alla inviolabilità del cromosoma x che vedremo di rispedire, e telegraficamente, a codeste
contemporanee reazioni cui tutto sembra essere permesso eccettoché realizzare
di essere già defunte, e di non avere altro dio all’infuori del loro sangue.