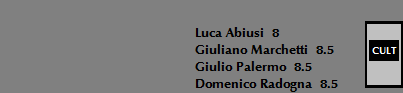Il
prerequisito della trasmissibilità genetica indiretta viene risolto con largo
anticipo dallo screenplay d’impenetrabile granito, escludendo anche le
verità induttive che competeranno il ritorno, vagamente teocentrico, del
maggiore Kusanagi. E verranno egualmente continuate le teorie con cui il
prequel si
ritrasse dai sentieri della intelligenza artificiale in soluzione di
policarbonati e tessuti compensativi, giacché l’uomo, salvo d’intenzioni, si
troverà condannato a commutare in dote biologica qualunque sua azione
proferibile all’espandibilità (e alla condivisione) del patrimonio menemonico
acquisito, riguardasse questo gli sconfinati quartieri di super palazzi – come
moduli aggiuntivi di Ram esterna – o che si parli di visori olografici e di
banche dati analogiche o digitali da impiantare (o erigere) sulle matrici dell’interlegere. L’autodeterminazione, criminosa, di un esercito di “sexoidi” che decide
di cessare di essere consegue il fallimento dell’innesto periferico e seriale
dello «spirito», visto l’istinto di negazione che l’organismo ospite svilupperà
sotto forma di “anticorpo dell’anima”. È la struttura del ricordo, mancante nel
ginoide al silicone ma presente nel cyborg Batou, anello di giuntura tra carne e
macchina, a rendere in qualche modo l’accettazione della essenza di sé.
Il
prerequisito della trasmissibilità genetica indiretta viene risolto con largo
anticipo dallo screenplay d’impenetrabile granito, escludendo anche le
verità induttive che competeranno il ritorno, vagamente teocentrico, del
maggiore Kusanagi. E verranno egualmente continuate le teorie con cui il
prequel si
ritrasse dai sentieri della intelligenza artificiale in soluzione di
policarbonati e tessuti compensativi, giacché l’uomo, salvo d’intenzioni, si
troverà condannato a commutare in dote biologica qualunque sua azione
proferibile all’espandibilità (e alla condivisione) del patrimonio menemonico
acquisito, riguardasse questo gli sconfinati quartieri di super palazzi – come
moduli aggiuntivi di Ram esterna – o che si parli di visori olografici e di
banche dati analogiche o digitali da impiantare (o erigere) sulle matrici dell’interlegere. L’autodeterminazione, criminosa, di un esercito di “sexoidi” che decide
di cessare di essere consegue il fallimento dell’innesto periferico e seriale
dello «spirito», visto l’istinto di negazione che l’organismo ospite svilupperà
sotto forma di “anticorpo dell’anima”. È la struttura del ricordo, mancante nel
ginoide al silicone ma presente nel cyborg Batou, anello di giuntura tra carne e
macchina, a rendere in qualche modo l’accettazione della essenza di sé.
Si discorre altrimenti, in Innocence, non solo di
tecnocrazia e surrogati che intendono prendere il posto di quel che rimane della
manovalanza umanoide depotenziata. L’aria è irrespirabile, e si sapeva. E
vengono costruite automobili che assumano scocca di cimeli anni ’50 per
esercitare il contrasto col morente cielo arancione scrutabile dal finestrino,
sfondo costante, castrante irreversibile ma il film, trasversale, rovescia
nell’austera eviscerazione sin da che si manifestano i primi sintomi
dell’insofferenza che Oshii reca nei confronti dell’umanità indistinta, stirpe di
organismi che si macchia della presunzione di sostituirsi a Dio, che è il
dio medesimo del sottogenere alimentato a micro-combustione atomica dal cui metabolismo a
nano cellule si dovranno scandagliare e poi recidere le barriere circoscriventi le vastità reticolari, le connessioni infinite oltre l’umano,
oltre le macchine; una volta ancora si tenta di agire sul noir investigativo a
base complottista con l’idea di contenere l’invasività del messaggio proveniente
dalla instabile postazione di regia, dacché quasi Oshii ricusa la centralità
funzionale di cinepresa e direzione artistica, quand’anche a ricadere nel
grandangolo di un paio d’inquadrature oltre cui tradirsi di codice
identificativo e numero di previdenza sociale, assumendosi il rischio
dell’ingerenza del soliloquio sull’affiche esteriore e bypassando di netto le
semplificazioni del gesto animato.
Facendo capo ai suoi deputati sintetici, la
sostanza biologica potrà infine ritrovarsi. E sopravvivere. E ciò malgrado si
leva con rinnovata decisione il quesito sulla disperdibile riconoscibilità
cognitiva, che non può ridursi al mastice antiscientifico della
frenologia ma di converso evolvere in una stadiazione asimmetrica, subatomica,
similmente mistica discorrendo sulle maschere atterrenti del “carnevale” in 3D
silicon graphics artefatto e deistico, qual è il ritratto divino di un Buddha, una effigie al cui
cospetto sacrificare il retaggio della scienza che non detiene risposta. È
fuori dubbio l’occasionale ricalco dei convincimenti e degli assilli che il
regista mira ad assecondare nel merito della subornazione della robotica,
oggetto di controversia fin da quando gli erano stati commissionati i due film
cinematografici di Patlabor, e di certo manca a Innocence la manualità del suo
predecessore disegnato a celle da milleuno dettagli che sembrano moltiplicarsi
quanto i bacilli, ché a inizio 2000 si stava nella fase dell’aggressione al
rendering tridimensionale e riusciva difficile di venire traviati dal ray
tracing di qualche mezzo di trasporto fluttuante o dai frammenti del vetrame,
e si doveva giustamente riprodurre modelli anatomici full body che
servissero da orientamento per il successivo Ghost in the Shell 2.0. Il film
dimostra una personalità lacerante. Vi è di che fuoriuscire discretamente lividi
dal reset del cerebro e del tempo, che si riavvia in loop –
autocitazione colta – e non sai dove ti trovi fino al segmento finale guerresco
e in una certa misura inatteso, nell’attesa del fotogramma degli occhi della
bambola, che prelude
alla dissolvenza.